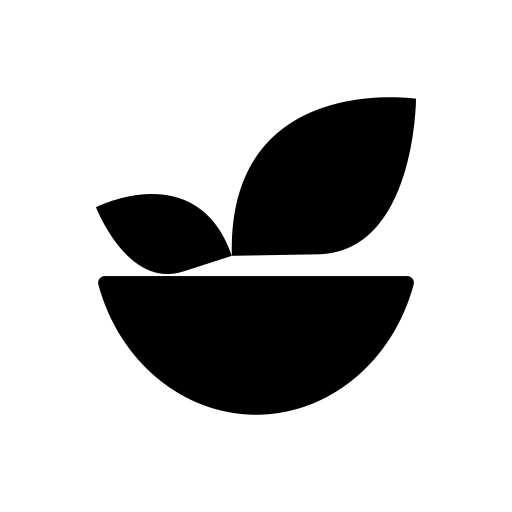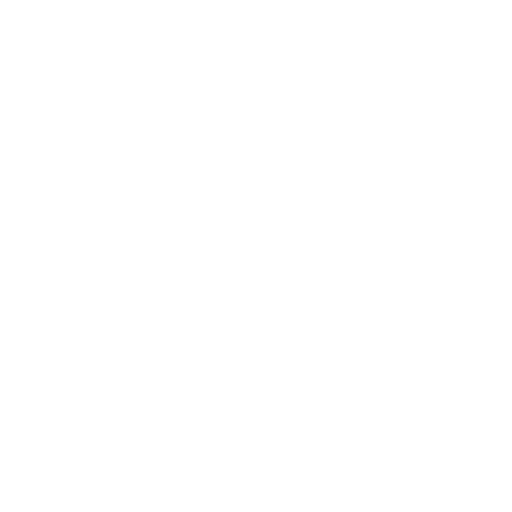Prima di catturare la realtà in un’immagine, posso metterne a fuoco piani differenti, e con questa azione dare luogo ad altrettante fotografie di essa che mi fanno percepire il mondo intorno, non solo da un certo punto di vista, ma con significati che gli elementi in evidenza, quelli cioè ritagliati dallo sfondo, rendono possibili. Il resto diventa secondario, scontato, quasi cessa di esistere, cioè cessa di «stare saldo» fuori dallo sfondo stesso, come vuole l’etimologia della parola ex-sistere. Per contro, lo sfondo diventa un oggetto in apparenza inerte: poiché è indistinto, esso perde l’attenzione di chi lo guarda. Ma, appunto, l’effetto è solo apparente, dato che senza di esso, senza questo oggetto di contrasto che stacca dal vissuto alcuni aspetti e ne trattiene nascosti altri, il primo piano non avrebbe senso.
In altri termini, la presenza dello sfondo retroagisce continuamente sull’immagine o sull’esperienza che sto considerando; esso è una parte determinante della realtà ed è anzi la condizione senza la quale quest’ultima non avrebbe senso. Vale per un paesaggio; ma vale altrettanto per una relazione rispetto alòa quale pongo attenzione su alcune caratteristiche di una persona o su alcuni elementi della narrazione che di sé mi propone; o, ancora, vale per uno stato d’animo per il quale solo di alcune parti trovo le parole, mentre altre sembrano dissolversi in uno sfondo indistinto prima che abbia potuto darne una definizione.
A prescindere però dal tipo di vissuto che prendo in esame, è proprio ciò che non viene guardato, che non viene detto, a rendere manifesto il primo piano. Se posso pronunciare un’esperienza, cioè se la posso qualificare, descrivere e comunicare, è proprio perché c’è qualcos’altro in essa su cui invece non riesco a dire alcunché: qualcosa che persiste, che non è indifferente, ma che sfugge al controllo perché si è inabissato nell’illusoria inerzia dello sfondo. Questa parte – «nascosta» nel senso che è fuori dal fuoco della mia attenzione, che potremmo dire presente ma inconscia – da un lato determina quale piano di realtà sto vivendo e, dall’altro, a differenza di una fotografia che ormai è completamente data, preme continuamente sull’esperienza. Spesso lo fa a nostra insaputa. Qualche volta la sconvolge, imponendo una messa a fuoco del tutto diversa da quella abitualmente utilizzata. Questo capovolgimento di prospettiva diventa ancora più dirompente in prossimità di eventi imprevedibili: un innamoramento folle, la perdita improvvisa di qualcuno, l’ingresso nella mia vita di una malattia importante, la nascita inattesa di un figlio.
Ma cosa accade se, come nell’immagine qui proposta1, viene volutamente esercitato lo scambio tra lo sfondo e il primo piano? Accade allora che l’atteggiamento spontaneo, naturale, di usare una «profondità di campo» concettuale, mettendo a fuoco alcuni elementi e lasciando che se ne confondano altri, viene sospesa. In questa forma, ascrivibile quasi a una epoché fenomenologica2, diventa immediatamente chiaro che lo sfondo, solitamente inosservato, ha un ruolo dirimente. Una volta diventato consapevole, questo esercizio consente di accedere a quei piani dell’esperienza – e, in qualche modo, della coscienza – che erano rimasti eclissati. Ciò che prima era in ombra, ora prende forma e luminosità: non è più necessario che un evento sconvolgente intervenga nelle nostre vite a indicare la possibilità di piani alternativi, o il logoramento dei piani di esperienza già vissuti, a volte obsoleti o esauriti; questa azione può essere condotta, invece, con cognizione di causa e portata a compimento, seppure in alcuni casi con la necessaria radicalità di una conversione, in maniera quasi deliberata, quantomeno guidata da un certo sforzo di autoeducazione che conduce a una trasformazione equilibrata di sé.
Tali trasformazioni, che ogni percorso di vita si porta dentro, possono essere considerate come la transizione da un piano all’altro dell’esperienza. Ciò che prima era sullo sfondo, ora sale in primo piano; e viceversa, ciò che prima rappresentava il focus della mia attività viene intenzionalmente relegato su un piano secondario a costituire una storia e una memoria che tracciano, come un’eco di cui riascoltare la voce, il racconto del viaggio compiuto. Se non ci fosse questo racconto, ogni piano, e dunque ogni esperienza, risulterebbe equivalente all’altra; non ci sarebbe modo di stabilire cosa mettere a fuoco oggi rispetto a ieri, né sarebbe possibile esercitare lo scambio tra sfondo e primo piano con cui delineare un quadro di senso e di valori per il periodo di vita in corso.
In un’epoca come la nostra, che fa dell’attualità quasi un criterio identitario – vale a dire: io esisto, sono visibile agli altri nella misura in cui mi faccio vedere sulle piattaforme sociali, sono informato sulle notizie, sono in linea e performante con le innovazioni e le possibilità offerte dal mio tempo – guardare lo sfondo, restare sullo sfondo, almeno quel tanto che basta per porsi la domanda «cosa conta per me in questo momento?» potrebbe apparire inefficace. E, tuttavia, la capacità auspicabile di rimanere inattuali, per usare una celebre espressione di Nietzsche, ha il pregio di mostrare le tendenze che si muovono sullo sfondo, sia di una fase storica sia della vita personale, restituendo alla cose, qui e adesso, le dimensioni e i rapporti che tra loro meritano di avere.
In breve, soffermarsi, interrogarsi sullo sfondo quel tanto che basta per non farsi travolgere dall’eterno presente nel quale tutto è urgente, è una pratica funzionale a restituire senso e spessore ai percorsi della nostra esistenza. D’altra parte, non c’è «immagine» (fotografia, opera d’arte, ma anche testo, discorso, film, brano musicale) in cui lo sfondo sia insignificante: esso è piuttosto la misura con cui, inconsapevolmente, giudichiamo la sua qualità e la natura del messaggio che ci comunica.
- Valentino Francoli, Nei suoi pensieri, Instagram, 2024 ↩︎
- E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino, 1965, pagg. 65-67 ↩︎